A pensare si fa peccato, ma ci si azzecca
Nato e cresciuto nell'entroterra fiorentino, dopo le superiori studia Filosofia presso l’Università di Pisa, approfondendo temi di filosofia analitica e scrivendo una tesi in filosofia del linguaggio, logica e ontologia formale. Attualmente lavora come programmatore, continuando a coltivare l’interesse per la filosofia, soprattutto in relazione alla programmazione e all’intelligenza artificiale.
Dal "gioco del dare ragioni" allo storytelling del mercato, dove i modelli predittivi rischiano di sostituire la razionalità
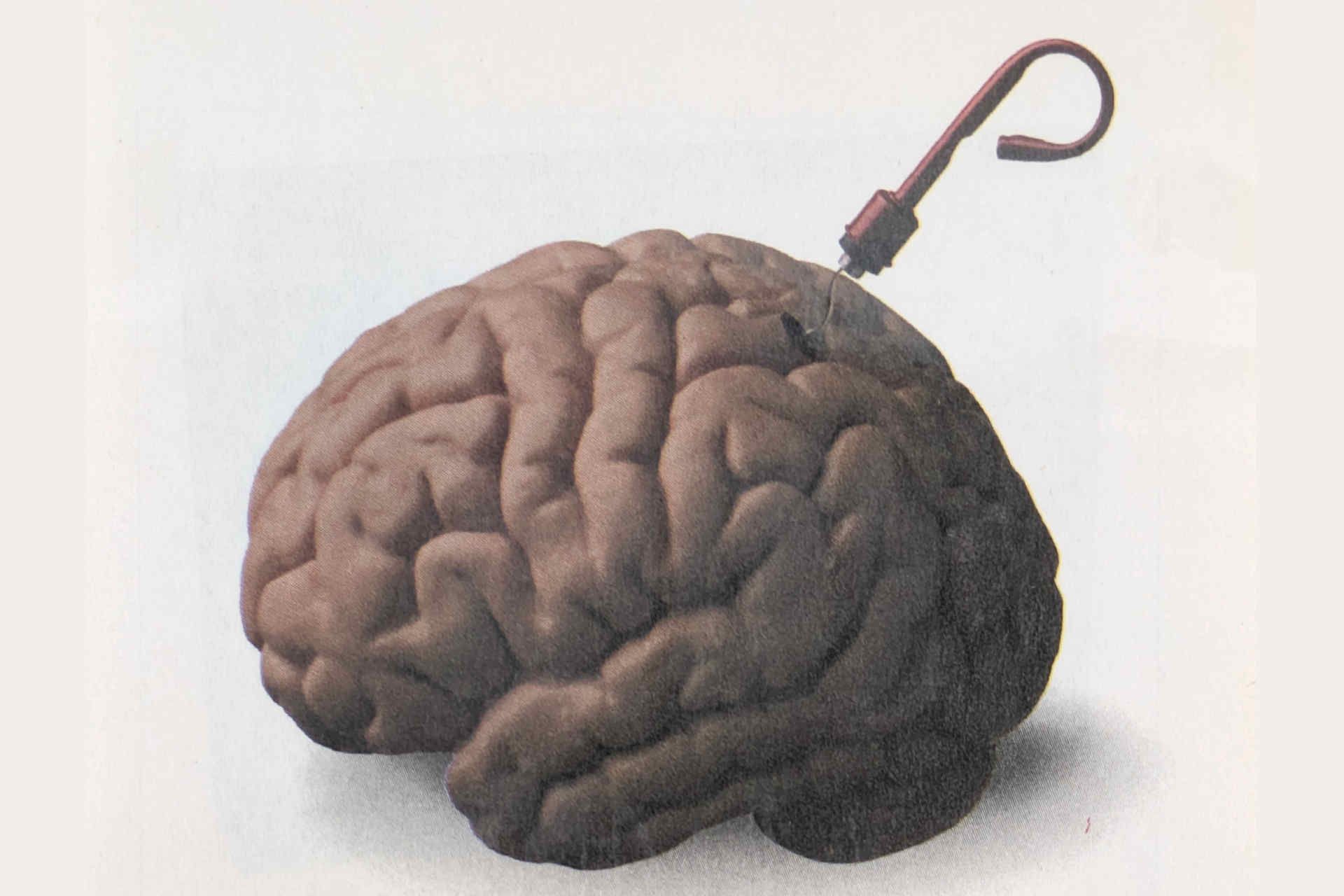 «Qualche volta si pensa per la cosa [fino a ora] ha dato buoni risultati», diceva Wittgenstein nelle _Ricerche Filosofiche_, §470 (tranne il commento tra parentesi). Quando, in epoca moderna, emerse il bisogno di ritrattare i fondamenti della filosofia, dando all’epistemologia un ruolo più importante rispetto alla metafisica, i filosofi cercarono di fornire un metodo rigoroso per dare spiegazioni: un metodo alternativo al sentito dire e al riferimento all’autorità.
«Qualche volta si pensa per la cosa [fino a ora] ha dato buoni risultati», diceva Wittgenstein nelle _Ricerche Filosofiche_, §470 (tranne il commento tra parentesi). Quando, in epoca moderna, emerse il bisogno di ritrattare i fondamenti della filosofia, dando all’epistemologia un ruolo più importante rispetto alla metafisica, i filosofi cercarono di fornire un metodo rigoroso per dare spiegazioni: un metodo alternativo al sentito dire e al riferimento all’autorità.
L’amore per la conoscenza (che lo si chiami “filosofia” o con il nome di un’altra scienza) nasce con due domande: “Che cos’è?” e “Perché?”. È in quanto esseri razionali che sappiamo rispondere a queste domande e porne sia il ruolo che le risposte in un quadro teorico che restituisce il senso della nostra appartenenza a una comunità. È qui che entra in gioco il normativismo: appartenere a una comunità significa essere soggetti a delle regole, insieme agli altri membri, e quindi rispondere a degli obblighi. Sapere rispondere a “Che cos’è?” e “Perché?” significa saper giocare a quello che Robert Brandom chiama “gioco del dare e chiedere ragioni”: cioè il gioco in cui rendiamo espliciti i nostri impegni epistemici e semantici.
Nelle varie scacchiere in cui il nostro intelletto ci permette di muoverci, la conoscenza delle regole presuppone la capacità di rendere esplicite le ragioni delle nostre mosse. Nel gioco della fisica, sapere che l’atomo di idrogeno ha solo un elettrone richiede che si sappia dare delle ragioni, delle motivazioni, delle giustificazioni. Esprimere un giudizio, cioè asserire qualcosa di cui ci impegniamo a sostenere la verità, significa prendere posizione in una delle caselle della scacchiera. È possibile mantenere quella posizione in due modi: seguiamo la regola del gioco senza conoscerla oppure conosciamo la regola e la sappiamo applicare. Nel primo caso, ci limitiamo a conformarci alle regole del gioco, nel secondo caso sappiamo giocare al gioco linguistico del dare e chiedere ragioni.
La conoscenza guida le nostre azioni e necessita di essere giustificata tanto quanto le azioni stesse. Per questo, fare riferimento all’autorità o credere a qualcosa solo per sentito dire impedisce di giustificare quanto detto o fatto, salvo ovviamente uscirsene fuori con un _ipse dixit_. Certo, non tutti siamo produttori di significato allo stesso modo: c’è bisogno di distinguere chi produce e chi consuma (dicendolo con Gareth Evans in _The Varieties of Reference_ ) o, in generale, di dividere il lavoro linguistico (dicendolo con Hilary Putnam in _The meaning of “meaning”_ ). Di fronte a questa divisione, entra in gioco la fiducia, nel ruolo fondamentale che gioca nelle pratiche linguistiche.
Se accettiamo che la semantica dipenda dalla pragmatica (cioè che il significato dipende dall’uso, che la significazione dipende dalle pratiche linguistiche, che le inferenze permesse dai concetti trovano fondamento nella normatività delle pratiche discorsive), come sembra naturale fare una volta riconosciuta la natura sociale del linguaggio, dobbiamo anche fare i conti con la fiducia tra i parlanti che sta alla base proprio delle pratiche linguistiche e della formazione di comunità linguistiche, come ci ricorda Giacomo Turbanti in _The Constitutive Role of Trust in Semantics_ : l’affidabilità si misura nel gioco del dare e chiedere ragioni, cioè dalla nostra capacità di giustificare ciò che diciamo.
La fiducia nell’impegno semantico ed epistemico altrui implica la nostra disponibilità a considerarlo un punto di riferimento, una fonte. La storia apparentemente contraddittoria che ci troviamo a vivere è che, nel mondo capitalista, il gioco del mercato sostituisce il gioco del dare e chiedere ragioni: siamo tutti merce, dice Marx nei _Manoscritti Economico-Filosofici_ del 1844, e per sopravvivere dobbiamo vendere noi stessi. Allora il nostro appartenere a una comunità non è dato dalla nostra capacità di sostenere il peso degli impegni semantici ed epistemici, ma dalla nostra capacità di raccontare una storia, coerente quanto possa essere, per far sì che il nostro posto nel mercato sia quantomeno mantenuto, se non addirittura promosso. È lo _storytelling_ , cioè l’arte della finzione, che ci guida nel mercato: in quanto merci, venditori e clienti dell’altrui storia, mossi e non moventi nel quadro normativo promosso dall’ultima campagna di marketing.
In un mondo in cui le relazioni sociali sono appiattite sulla dimensione grafica dei social network, la razionalità stessa risente del ridimensionamento della fiducia nei termini del favore riservato a chi seguiamo oppure, che è il problema di questo periodo, all’intelligenza artificiale a cui affidiamo i nostri pensieri e i nostri problemi.
Affidarsi a un predittore di testi, come le intelligenze artificiali di cui facciamo uso (ChatGPT, Gemini, Claude, eccetera), è come affidarsi allo storytelling su cui si basano molte campagne di marketing: un modello linguistico dice quel che ritiene più probabile, così come una campagna di marketing mira a costruire la narrazione che con più probabilità attirerà il favore della clientela. Qui, del gioco di dare e chiedere ragioni, trova posto soltanto un simulacro, fatto di merci e allucinazioni, atte soltanto a rivedere il nostro comportamento in vista del prossimo acquisto e il pensiero non dà più buoni risultati.